
Valori e parametri dell’acqua
I valori e i parametri dell’acqua rappresentano un importante aspetto da conoscere e misurare (con i test) settimanalmente o almeno ogni 15-20 giorni.
Nell’articolo chimica dell’acqua si è fatto un breve accenno alla composizione chimica dell’ H2O ed al suo valore principale, ovvero il PH. Ci sono, tuttavia, altri valori e parametri dell’acqua da prendere in considerazione quando si vuole mantenere in salute le specie di pesci e di piante presenti in acquario.
La durezza dell’acqua
Il kH
Il KH, chiamato anche durezza carbonatica o temporanea dell’acqua, agisce da tampone nei confronti del PH, opponendosi alla sua variazione. I valori ottimali del KH per l’acquario tropicale di acqua dolce sono compresi tra 3 (in nessun caso inferiore) /4 /5 (per una fertilizzazione ottimale con CO2 ) e 10. Nell’acqua marina, invece, per mantenere la capacità di tamponamento, la durezza carbonatica dev’essere di circa 7- 13 °dKH. Solitamente in acquario si fa riferimento al grado tedesco (°d), ma esiste anche il grado inglese (°e) e francese (°f).
I sali responsabili della durezza carbonatica o temporanea sono principalmente i carbonati (-CO32-), i bicarbonati (-HCO3–) e i cloruri (-Cl–) di calcio e magnesio. I primi tendono ad evaporare con l’ebollizione, mentre gli ultimi tendono a permanere, andando così a costituire la durezza permanente. Il KH è prevalentemente formato da carbonati e bicarbonati (anioni, quindi ioni negativi). La somma della durezza temporanea e di quella permanente andrà a costituire il valore della durezza totale (°dGH).
Il potere tampone
Il potere tampone è strettamente collegato alla durezza dell’acqua. L’acqua dura con alcalinità maggiore è meglio tamponata rispetto a quella tenera, poiché presenta una concentrazione maggiore di minerali di calcio in primis e di magnesio. Tale potere tampone si può mantenere costante con regolari cambi d’acqua. Un’acqua con bassi valori di KH (come quella osmotica) avrà uno scarso effetto tampone sul PH dell’acqua che, inevitabilmente, tenderà ad oscillare, a seconda del rapporto tra ossigeno (O)/anidride carbonica (CO2). Il PH diverrà alcalino con una maggiore attivazione del depuratore ed una corrispondente ossigenazione, mentre tenderà a scendere verso valori più acidi con stagnazione ed immissione di CO2. Il potere alcalinizzante del KH contrasta un improvviso abbassamento del PH che, proprio perché repentino ed improvviso, può provocare danni in misura maggiore ai pesci e, secondariamente, anche alle piante.
Il GH
Il GH è determinato da ioni positivi (cationi) quali il calcio (Ca++) e magnesio (Mg++) e parlare della durezza dell’acqua significa prendere in considerazione le concentrazioni di calcio e magnesio.
Il primo è utile per la crescita della struttura delle pareti cellulari delle piante, mentre il secondo è un costituente essenziale nella produzione della clorofilla, di oli e di amidi. Un eccesso di calcio e di magnesio comporta una limitazione nell’assorbimento di altri nutrienti (per esempio il potassio negli eccessi di magnesio). Entrambi, se ben bilanciati, appartengono alle categoria dei macronutrienti, indispensabili ad una corretta e sana crescita della vegetazione acquatica.
Negli acquari di acqua salata, infine, il calcio ed il magnesio sono di estrema importanza per la crescita e lo sviluppo dello scheletro calcareo dei coralli.
Il GH rappresenta il valore della durezza totale dell’acqua. Tale valore è dato dalla somma della durezza temporanea (KH) e della durezza permanente. Quest’ultima, tuttavia, non è misurabile direttamente, ma solo attraverso la sottrazione della durezza temporanea da quella totale.
Durezza totale (GH) – Durezza temporanea (KH) = Durezza permanente
Normalmente, infatti, la durezza totale è superiore di due o tre volte quella temporanea; tuttavia, se il KH dovesse risultare superiore rispetto al GH, la durezza permanente sarebbe assente.
Il GH in acquario
Per una acquario di acqua dolce i valori e i parametri ottimali dell’acqua vanno da 5 a 12/15 °dGH fino ai 20°dGH per i Ciclidi africani.
Per un acquario di acqua salata, i valori del calcio partono da un minimo di 400 mg/l ad un massimo di 450 mg/l, mentre il range del magnesio va dai 1260 mg/l fino ai 1350 mg/l. Più elevata è la quantità di tamponi presenti nell’acquario di acqua salata, più risulterà facile mantenere il PH in zona basica. Periodicamente conviene disciogliere dei tamponi ed affidarsi all’inserimento di materiale calcareo nel fondale e nell’arredamento, in modo tale da garantire una cospicua riserva di sali.
Nell’acquario di acqua salata, quindi, è utile movimentare il flusso d’acqua affinché una cospicua parte di anidride carbonica si disperda, garantendo un PH stabile. La CO2, infatti, in acqua si trasforma in acido carbonico che, come abbiamo già visto, tende ad acidificare il PH.
Nell’acquario di acqua dolce con una discreta quantità di vegetazione, invece, abbiamo la situazione inversa. Il flusso d’acqua non dovrebbe movimentare eccessivamente l’acqua per non far disperdere l’anidride carbonica, utile alla fotosintesi clorofilliana delle piante. In acquari di acqua dolce con molta vegetazione (per esempio negli acquari di tipo olandese) sarà, inoltre, opportuno incrementare la quantità di CO2 con appositi distributori.
I composti azotati
Ammoniaca (NH3), ammonio (NH4), nitriti (NO2) e nitrati (NO3) costituiscono i composti del cosiddetto ciclo dell’azoto e rappresentano degli importanti valori e parametri dell’acqua da tenere sotto controllo.
Essi si accumulano costantemente nell’acquario, poiché provengono dalle sostanze di rifiuto dei pesci (urina, feci), dagli eventuali corpi di animali morti, dai detriti delle piante (maggiori per le piante a crescita rapida), dagli zuccheri, dai grassi, ma soprattutto dalle proteine dei mangimi somministrati dall’acquariofilo.
L’ammoniaca, il principale composto del metabolismo animale, è estremamente tossica già a basse concentrazioni, pertanto la sua presenza deve risultare nulla. Le proteine dei mangimi vengono trasformate in ammoniaca dai batteri decompositori. Tale sostanza tossica, legandosi agli ioni idrogeno (H+) diventa ammonio: maggiore è la concentrazione degli ioni idrogeno (quindi minore è il PH) maggiore sarà la percentuale di ammoniaca trasformata in ammonio (meno tossico dell’ammoniaca). L’ammonio, bisogna ricordare, è il composto prediletto di alcune specie di piante per l’acquisizione di azoto (importante macronutriente), utile per sintetizzare le proteine. L’ammonio in acqua acida e povera di sali risulta meno tossica, mentre in acquari con acqua dura e basica (con PH maggiore di 7) viene convertita in ammoniaca, estremamente pericolosa.
Nitriti e Nitrati
Se il filtro (in particolare quello biologico) ed il fondo sono sufficientemente maturi da ospitare la popolazione di batteri aerobi (Nitrosomonas), l’ammoniaca viene ossidata in nitriti. Essi appartengono al penultimo stadio del ciclo dell’azoto e sono altrettanto nocivi sia per i pesci che per le piante. Non devono superare lo 0,05 mg/l, poiché impediscono all’ossigeno di essere veicolato dall’emoglobina, portando dunque i pesci alla morte per asfissia, anche in presenza di acqua fortemente ossigenata.
Durante l’ultimo stadio della catena di decomposizione aerobica del ciclo dell’azoto, i nitriti vengono ossidati in nitrati da un gruppo di batteri chiamati Nitrobacter. Per diventare tossici i nitrati devono raggiungere concentrazioni ben maggiori rispetto all’ammoniaca ed ai nitriti. Se queste concentrazioni vengono protratte per lungo tempo possono provocare il mancato accrescimento (nanismo) dei pesci, sino alla morte improvvisa.
Come fonte azotata i nitrati vengono prelevati dalle piante per sintetizzare le proteine e quindi usati come fonte di nutrimento; tuttavia tale prelievo comporta un dispendio energetico maggiore rispetto a quello richiesto per l’utilizzo dell’ammonio. Se la quantità di nitrati risulta essere troppo elevata, oltre a compromettere la salute dei pesci, porta all’insorgenza di un eccessivo sviluppo algale. Se non si vuole ricorre all’utilizzo dei prodotti chimici, il metodo più pratico, per far diminuire la quantità di nitrati presenti in acquario, risulta essere quello dei cambi d’acqua costanti e regolari del 10-20% ogni settimana.
I fosfati e i silicati
I fosfati (PO43-) si trovano in buona quantità nei tessuti dei pesci come fonte energetica per le loro cellule, inoltre sono indispensabili allo sviluppo delle piante per la produzione del glucosio, infatti appartengono alla categoria dei macronutrienti. In natura, però, si assiste ad un’esigua concentrazione di fosfati, circa lo 0,005 – 0,02 mg/litro. Una massiccia presenza di questi sali è indice di inquinamento, mentre in acquario (sia di acqua dolce sia di acqua salata) determinano una smodata crescita delle alghe, in particolar modo di quelle macroscopiche, filamentose o a feltro. La concentrazione dei fosfati in acquario che, ricordiamolo è un ecosistema chiuso, può arrivare a 1 – 3 mg/litro e fondamentalmente proviene dagli alimenti, dai prodotti di scarto dei pesci e da alcuni fertilizzanti.
I silicati (SIO4)4-, invece, sono minerali che determinano una crescita delle cosiddette alghe microscopiche unicellulari, come per esempio le diatomee. Esse tendono a ricoprire di un velo brunastro gli arredi, i vetri, i coralli e le pietre.


Per eliminare questi indesiderati ospiti bisogna ricorrere a delle resine a scambio ionico da mettere dentro il filtro oppure, come sempre, a copiosi cambi d’acqua costanti e ripetuti. Quando si parla di alghe, l’importante è non demordere!
Altri elementi
Il cloro
Il cloro (Cl2) è un gas tossico per pesci quasi del tutto assente in natura. Viene usato dall’uomo per rendere potabile l’acqua che scorre nelle tubature domestiche e nelle piscine per disinfettare. Fortunatamente è un gas estremamente volatile, a differenza delle clorammine. Quando si mescolano l’acqua di rubinetto e l’acqua ad osmosi inversa, è una buona pratica utilizzare un bio-condizionatore che lega il cloro e le clorammine, in modo tale da non intossicare i pesci presenti in acquario. Il cloro rientra tra i micronutrienti per le piante, le quali l’assorbono per mantenere un equilibrio osmotico e per la fotosintesi.
Il ferro
Il ferro è presente in acqua in due distinte forme: bivalente (Fe++) e trivalente (Fe+++). La prima forma è solubile in acqua, mentre la seconda si lega ad altri composti, formando così gli ossidi ferrosi dal classico colore rossastro.
Per le piante è un micronutriente utilizzato per la respirazione, la produzione di enzimi e la sintesi della clorofilla. Tale metallo viene assorbito sia attraverso le foglie sia attraverso le radici. Per le piante è più utile in forma bivalente, mentre in presenza di ossigeno, il ferro si converte in trivalente, più difficile da assimilare. Per contrastare tale conversione, sono stati inventati dei chelanti, come il ferro chelato, che lentamente rilascia Fe++ (FeEDTA). In questo modo, i chelanti non permettono che il ferro possa legarsi con altri metalli, formando per ossidazione molecole più grosse.
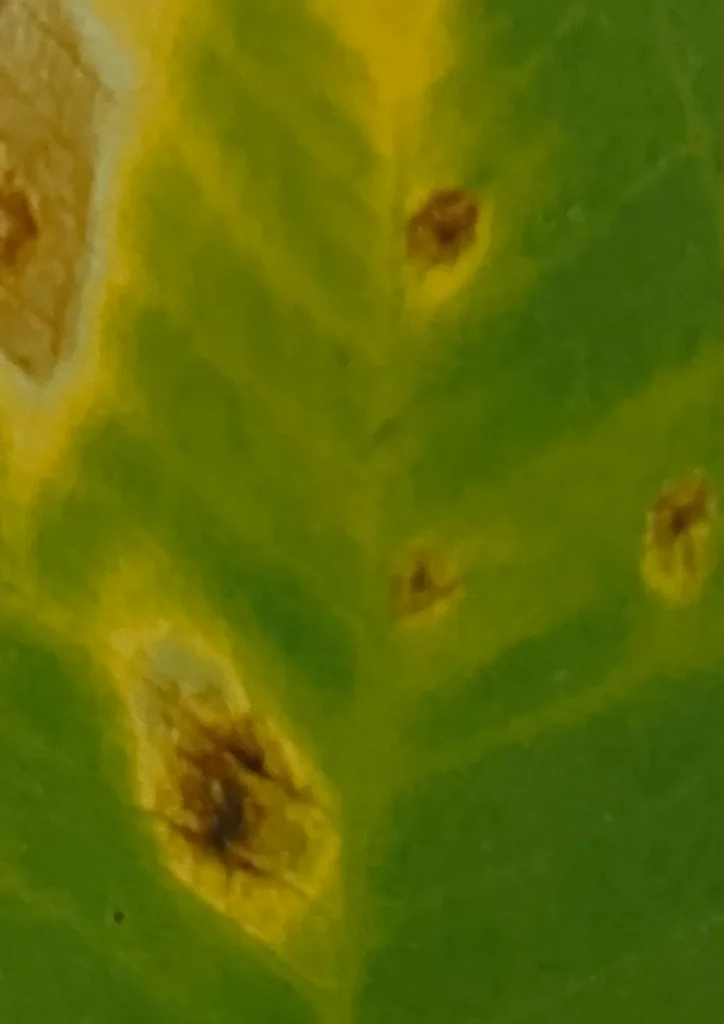
Il rame e lo zinco
Il rame (Cu++) lo zinco (Zn) sono presenti in tracce (0,05 mg/litro) nell’acqua potabile, ceduti dalle condutture, ma in un acquario possono risultare tossici per i batteri “buoni” del filtro biologico. Sempre in acquario, lo 0,1 mg/litro è già dannoso per le piante e per i pesci. Si possono eliminare dall’acqua, effettuando cambi d’acqua parziali e utilizzando delle apposite resine nel filtro.
Per la vita vegetale, essi rappresentano dei micronutrienti, utili agli enzimi per la respirazione cellulare e la produzione della clorofilla. Il rame, se è presente in eccesso, tende a macchiare le foglie di marrone ed a sfaldare i tessuti delle piante.
La temperatura
Tra i valori ed i parametri dell’acqua, la temperatura influenza qualsiasi reazione chimica, organica ed inorganica. E’ un parametro fisico che agisce sulla respirazione, sulla digestione e sull’assorbimento dell’ossigeno da parte dei globuli rossi e, in generale, sul metabolismo dei pesci, delle piante, delle alghe e degli invertebrati.
A temperature elevate, si pensi d’estate, la quantità dei gas disciolti in acqua diminuisce (O, CO2), la densità dell’acqua decresce, così come anche la tensione superficiale. L’elevata temperatura, invece, fa aumentare la conduttività, il potenziale redox (ossido-riduzione) e la pressione osmotica.
La conduttività
L’acqua di per sé è un cattivo conduttore di energia elettrica. Ciò che fa aumentare la sua conduttività è la quantità di sostanze polari disciolte in essa (acidi, sali, composti organici ecc…).
La conduttività (EC, ovvero Electrical Conductivity) misura con degli appositi dispositivi elettronici che utilizzano come unità di misura il microsiemens per centimetro (µS/cm). Per un acquario tropicale di acqua dolce, i valori ed i parametri ottimali dell’acqua si aggirano intorno ai 300-400 µS/cm. Più aumenta la temperatura dell’acqua, più aumenta la conduttività; quest’ultima infine è strettamente correlata alla durezza totale.
Come abbiamo visto in precedenza, la durezza totale rappresenta la quantità totale dei carbonati, dei bicarbonati e dei cloruri che, scindendosi, vanno a formare ioni positivi e negativi, ottimi veicoli della conduttività elettrica. La relazione tra conduttività, durezza totale e tensione superficiale è direttamente proporzionale. Se sono presenti molte sostanze polari, ovvero se la conduttività è elevata, gli ioni positivi e negativi formeranno una fitta rete sulla superficie dell’acqua, penetrabile solo dagli oggetti più pesanti. Questa tensione superficiale influenza la vita degli organismi vegetali ed animali (compresa la riproduzione delle specie ovipare).
Conduttività, tensione superficiale e pressione osmotica sono strettamente collegate. Più la conduttività è elevata, più la tensione superficiale aumenta e, con essa, anche la pressione osmotica. Se la conduttività è troppo alta, l’uovo deposto dal pesce può perdere acqua sino a raggrinzirsi, ma se è troppo bassa, l’uovo può gonfiarsi ed esplodere. Per misurare la conduttività nell’acquario tropicale di acqua dolce esiste un misuratore elettronico specifico.
I solidi totali disciolti
Tra i valori e parametri dell’acqua i solidi disciolti (TDS, ovvero Total Dissolved Solids) si riferiscono ai mg di soluti di calcio e magnesio disciolti in 1 litro di acqua. Nell’acquario tropicale di acqua dolce una concentrazione che va dai 100 a 200 ppm (parti per milione) equivale alle condizioni di GH ideali per la maggior parte dei pesci, invertebrati e piante. Un range che va da 100 a 200 ppm corrisponde ad un °dGH che va da 6 a 12. Per misurare la quantità dei solidi disciolti in acqua d’osmosi o di rubinetto prima dell’aggiunta in acquario, esiste un misuratore elettronico specifico.
La salinità
Il Mar Mediterraneo è caratterizzato da una salinità del 38 x 1000, mentre gli oceani hanno una salinità leggermente inferiore, ovvero 36 grammi di sale per ogni litro di acqua. Nei mari e negli oceani questa quantità totale di sali può lievemente differire, ma, nel complesso, la percentuale relativa dei singoli sali non cambia.
Nell’acquario di acqua salata, invece, la composizione dei sali disciolti può differire, risultando più instabile, rispetto ad un ecosistema aperto, quale può essere quello dei mari o degli oceani. Tale instabilità si palesa attraverso il PH, il quale tende solitamente a scendere verso valori meno alcalini.
La densità
La densità è strettamente correlata alla salinità ed alla temperatura. Per un acquario marino mediterraneo si dovrà rilevare ad una temperatura di 18° C una densità pari a 1028 ppm; mentre per un acquario marino tropicale ad una temperatura di 25°C dovrà rilevare una densità pari a 1024 ppm.
Quando la temperatura tende a salire, la densità scende, senza tuttavia intaccare la quantità di sali. Quest’ultimi influenzano inoltre la quantità di gas presenti in acqua, come per esempio l’ossigeno. Più sali ci sono in acqua, minore è la quantità di ossigeno a disposizione della flora e della fauna marina. Infine se la salinità diminuisce, diminuisce la quantità di tamponi che stabilizzano il PH.
Nei mesi più caldi, quando la temperatura aumenta, negli acquari di acqua salata si può aggiungere una piccola quantità di acqua dolce, facendo aumentare così la solubilità dell’ossigeno ed abbassando la densità di un paio di unità.
